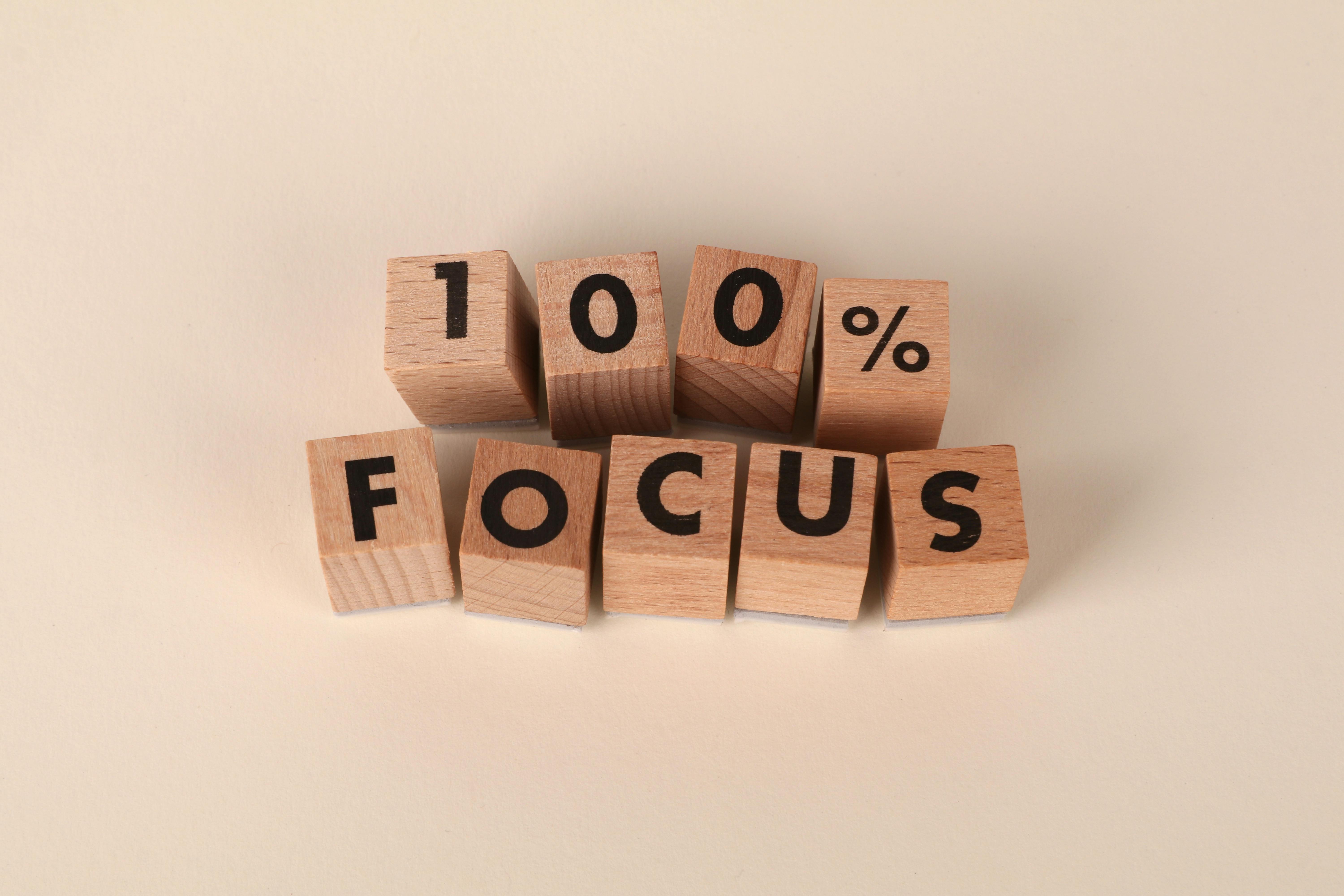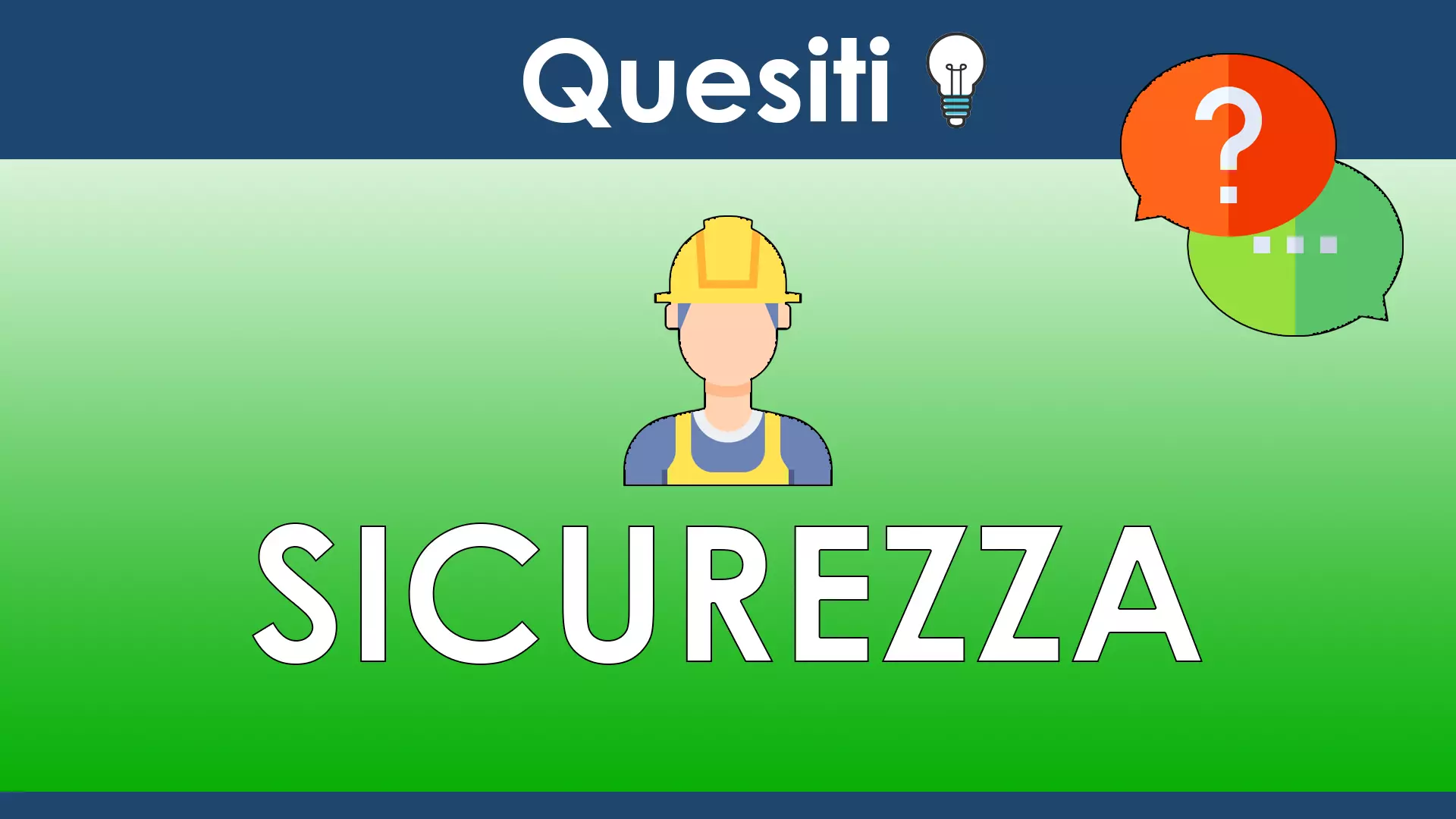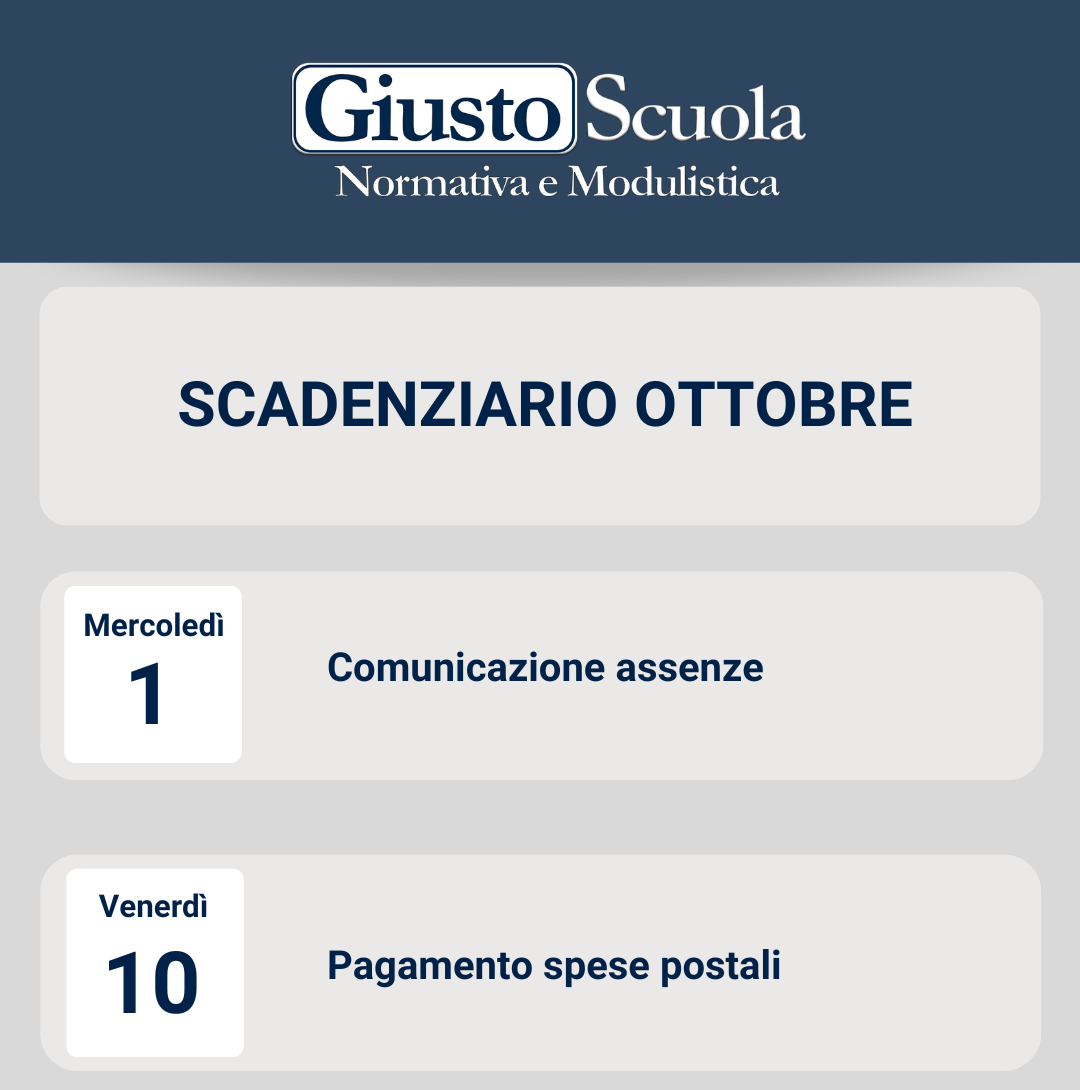Abbiamo avuto modo di rileggere in riviste on line di settore, anche con interventi di qualche sigla sindacale, di responsabilità erariali in ordine alla progettualità per l’attuazione del PNRR, dopo i non positivi controlli mirati dell’Unità di missione presso il MIM disposti nei confronti di dirigenti scolastici di alcuni istituti alberghieri, nautici e agrari; mentre una nota ministeriale – subito dopo sospesa ma non annullata – ha parimenti prefigurato una responsabilità erariale di chi si è attribuito i relativi compensi accessori nella misura integrale del 100% anziché dell’80%.
In entrambi i casi riteniamo che le posizioni assunte dall’Amministrazione sono prive di fondamento. E proviamo a motivarlo richiamando preliminarmente, in rapida sintesi, la normativa in materia.
1. È noto che la sussistenza di un rapporto di impiego, e nell’esercizio del medesimo, può esporre il dirigente scolastico (ma anche i docenti, il personale ATA e soggetti pur occasionalmente legati a un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione) alle diverse forme di responsabilità previste dall’ordinamento giuridico, che possono ben concorrere in un’unica azione od omissione.
Una tipologia di responsabilità, riguardante i predetti soggetti qualificati, è quella amministrativa, che si fa valere davanti la Corte dei conti. Consiste nell’inosservanza dolosa o colposa dei doveri d’ufficio o di servizio che abbiano recato pregiudizio alla sfera patrimoniale dell’Amministrazione; usualmente suddistinta in responsabilità patrimoniale in senso stretto, responsabilità contabile e responsabilità disciplinare.
Di quest’ultima nulla si dirà, essa meritando una distinta disamina in apposita sede; mentre è qui bastevole un cenno alla responsabilità contabile (sottospecie della responsabilità patrimoniale), propriamente riferibile a tutti coloro che, nell’espletamento delle loro funzioni o mansioni, maneggiano pubblico denaro o sono consegnatari di beni della P.A. (di norma il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi, ma anche un docente che agisca per delega e/o in sostituzione del dirigente scolastico, ovvero qualsivoglia sub-consegnatario).
Se accertata, essa importa un’obbligazione risarcitoria: che però si configura non già in ipotesi di mera irregolarità formale, ma solo in relazione al concreto danno arrecato, cioè alla deficienza qualitativa o quantitativa dei beni o dei valori maneggiati o in custodia, riscontrabile nel c.d. giudizio di conto, sempre salva la possibilità dell’agente di fornire giustificazioni.
Ancora, in tale forma di responsabilità e a differenza di quel che subito si dirà per quella patrimoniale, non sussiste il potere riduttivo della Corte, né vale il principio della divisibilità dell’obbligazione risarcitoria nel caso di più responsabili (e quindi si applica la regola generale della solidarietà passiva ex art. 2055 c.c.).
2. La responsabilità patrimoniale (o amministrativo-patrimoniale) – qui di più diretta attinenza – è, nella sostanza, una particolare forma di responsabilità civile, che però nasce da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Essa sorge in conseguenza di un danno arrecato all’integrità del patrimonio dell’erario, direttamente o anche indirettamente, come quando l’Amministrazione è costretta a risarcire il danno a un terzo per comportamento illegittimo di un proprio dipendente.
I presupposti giuridici della responsabilità in esame sono pertanto: il danno, la colpevolezza, la sussistenza del rapporto d’impiego o di servizio in relazione all’azione o all’omissione poste in essere, il rapporto di causalità tra il danno e la suddetta azione o omissione.
L’obbligo risarcitorio è escluso, oltre che dalle tipiche evenienze, di valenza generale, quali l’incapacità di intendere e di volere, lo stato di necessità, il caso fortuito e la forza maggiore, anche dal fatto di aver dato esecuzione a un ordine che si era tenuti ad eseguire in adempimento del dovere gerarchico di obbedienza (factum principis). Al riguardo l’esecuzione dell’ordine del superiore – che inerisca, beninteso, all’esercizio delle pubbliche funzioni al medesimo attribuite – dev’essere ottemperata, anche se lo stesso appaia palesemente illegittimo, se rinnovato per iscritto in seguito alla rimostranza dell’impiegato. In tal modo risponde chi ha dato l’ordine. Ordine che in nessun caso va però eseguito se viola la legge penale o diritti costituzionalmente tutelati.
Il giudizio di responsabilità patrimoniale è, come accennato, di competenza esclusiva della Corte dei conti. In caso di corresponsabilità di più soggetti, l’articolo 82 della basica legge di contabilità (R.D. 2440/1923) fa prevalere il principio della divisibilità dell’obbligazione risarcitoria su quello generale della solidarietà ex art. 2055 c.c. Peraltro, una volta accertato l’ammontare del debito, la Corte ha il potere di ridurlo, con valutazione ampiamente discrezionale (ante).
Occorre però considerare che la disciplina della responsabilità amministrativa in senso ampio (cioè sia patrimoniale che contabile) è stata profondamente rivista dalla legge 639/1996 sull’ordinamento della Corte dei conti, riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371/1998.
La nuova conformazione poggia sui due principi della responsabilità limitata al dolo o alla colpa grave, nonché della sua intrasmissibilità agli eredi, salvo il caso d’illecito arricchimento degli stessi.
Nella stessa logica che vuole un’amministrazione snella ed efficiente e non segnata da rallentamenti, eccessive titubanze, inerzie dei funzionari, si colloca infine la riduzione del periodo di prescrizione del danno all’erario da dieci a cinque anni.
3. Poste queste premesse di ordine generale, il primo dei due nodi da sciogliere concerne l’attuazione della progettualità afferente al PNRR, nello specifico il ritenuto artificioso frazionamento per sottrarsi alle procedure – e più stringenti vincoli – sopra la soglia comunitaria (euro 143.000,00, iva esclusa, per appalti pubblici di forniture e servizi; euro 5.538.000,00, sempre iva esclusa, per appalti di lavori pubblici e concessioni).
Il divieto di frazionamento è sancito nel D. Lgs. 36/2023 (che riprende l’analoga previsione del precedente D. Lgs. 50/2016). Ma, per l’appunto, se è artificioso, cioè posto in essere dolosamente – con coscienza e volontà – per evitare l’applicazione delle norme del codice. E comunque artificioso non è “nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”: ragioni che ben possono essere la diversa tipologia delle due o più forniture, il ridotto lasso di tempo per la realizzazione e il collaudo delle attrezzature in assenza di proroga, la difficoltà di reperimento sul mercato e nel periodo estivo-feriale di fornitori in grado di consegnare a corpo in tempi celeri i beni, contemporaneità di tanti progetti PNRR (DM 170/2022, DM 19/2024, DM 65 2023, DM 66/2023), ferie dovute/obbligate del personale scolastico. Ovvero il frazionamento in più lotti – per forniture omogenee – può essere legittimamente previsto (nel senso che vi si può ricorrere) anche per ragioni puramente organizzative, ma comunque nel sostanziale rispetto delle regole della concorrenza e di apertura delle gare al più ampio numero di partecipanti (così Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2346).
Pertanto – in disparte ogni considerazione di risposte in fotocopia dell’Unità di missione presso il MIM alle istituzioni scolastiche sottoposte a (non positivo) controllo, che “non sono stati rinvenuti elementi tali da escludere l’esistenza dell’irregolarità” e quindi avanzandosi l’ipotesi di “restituzione dell’intero finanziamento su richiesta dell’area pagamenti” – non esiste in radice qualsivoglia profilo di danno erariale, ancorché lo si sia infine prospettato.
Perché non esiste – allegandosi a motivazione una o più delle ragioni poc’anzi esemplificate – né il dolo né la colpa grave, che del danno erariale sono elementi costitutivi: e che eventualmente dovrebbe provare la Procura generale della Corte dei conti, dimostrando che i soggetti agenti (id est, il dirigente scolastico e/o il DSGA in concorrenza) abbiano posto in essere un preciso disegno di arrecare un predeterminato danno all’Amministrazione. E non si vede proprio, nel caso di specie, quale pregiudizio possa essersi consumato sull’integrità del patrimonio erariale, dato che l’Amministrazione (rectius: l’istituzione scolastica) ha ricevuto l’esatta controprestazione in beni/servizi oggetto dei contratti stipulati.
Ne è ulteriore riprova di quanto dedotto la cd. proroga dello scudo erariale, al 31 dicembre 2025, disposta dal D.L. 12 maggio 2025, n. 68, che riguardo la responsabilità erariale del soggetto agente ne espunge la colpa e la limita al dolo, sempre inteso come coscienza e volontà di cagionare danno alle finanze dello Stato: limitazione che però non si applica per i danni conseguenti a sua omissione o inerzia, giusto a ri-significare la prevalenza del principio di risultato. Principio di risultato che “è parte della legittimità stessa dell’atto amministrativo” (così il consigliere di Stato Luigi Carbone, già coordinatore della Commissione di lavoro per il nuovo codice dei contratti, poi emanato con D. Lgs. 36/2023, cit.); e che costituisce il cardine della – ulteriore – riforma in corso della Corte dei Conti, figurante nel disegno di legge appena licenziato da una delle due Camere.
4. Il secondo nodo – o presunto tale – involge i compensi accessori inerenti la progettualità imposta ai dirigenti scolastici nell’attuazione obbligatoria del PNRR, altresì preminente oggetto di valutazione di risultato e dei comportamenti organizzativi, di cui all’articolo 13 della legge 106/2024, di conversione del decreto legge 71/2024.
Sollecitata dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, la Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con nota prot. 46871 dell’11 dicembre 2024 ha risposto che i dirigenti scolastici possono legittimamente percepire nella misura integrale i compensi riguardanti l’attuazione dei progetti a valere sui PON (fondi FSE e FESR), vieppiù – o in quanto? – perché esplicitamente previsti dalla nota ministeriale 11130 del 30 settembre 2008. Mentre tale previsione è assente per l’attuazione dei progetti del PNRR, benché anche questi finanziati dall’Unione europea e parimenti obbligatori. Dunque – prosegue la nota, con un’ardita acrobazia linguistica e un uso davvero creativo della logica – “nonostante vi sia un obbligo per il dirigente di attuare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non vi è – tuttavia – un obbligo di assumere incarichi aggiuntivi. Di conseguenza, la differenza delle due discipline (?) implica una diversa attuazione, non potendo essere formulate interpretazioni analogiche tra i due istituti, rimanendo ancora attuale per i fondi PNRR la ritenuta del 20% da trattenere sul relativo Fondo nazionale ex art. 4, comma 2 CCNI 01/08/2023”.
Per il vero, anche per i fondi PNRR la provvidenziale (?) superiore nota esplicativa è sopraggiunta e appena una settimana dopo (n. 8810 del 18.12.2024, a firma dell’allora capodipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale). Per (non) dire, con l’immarcescibile clausola di stile, che “sono in corso ulteriori valutazioni ed interlocuzioni con gli uffici competenti (e) nelle more di questa attività istruttoria si prega pertanto di non tener conto di quanto rappresentato nella nota in questione (id est, n. 46871 dell’11.12.2024).
Delle predette “ulteriori valutazioni ed interlocuzioni” – se mai siano state avviate – non vi è ancora traccia, dopo circa sette mesi. A giusta ragione, potrebbe dirsi. Ché se mai una risposta dovesse arrivare, non potrebbe essere diversa da quella contenuta nell’articolo 19 del CCNL Area V dell’11 aprile 2006 (già articolo 26 del CCNL 1 marzo 2002), laddove nel comma 1, lettera h) si legge agevolmente che tra gli incarichi che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare figura “ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalle norme vigenti”.
In ogni caso, trattandosi – quel 20% – di risorse finanziarie da versare sul fondo nazionale e finalizzate all’incremento della retribuzione di risultato per tutta la categoria, dove sarebbe il danno erariale?