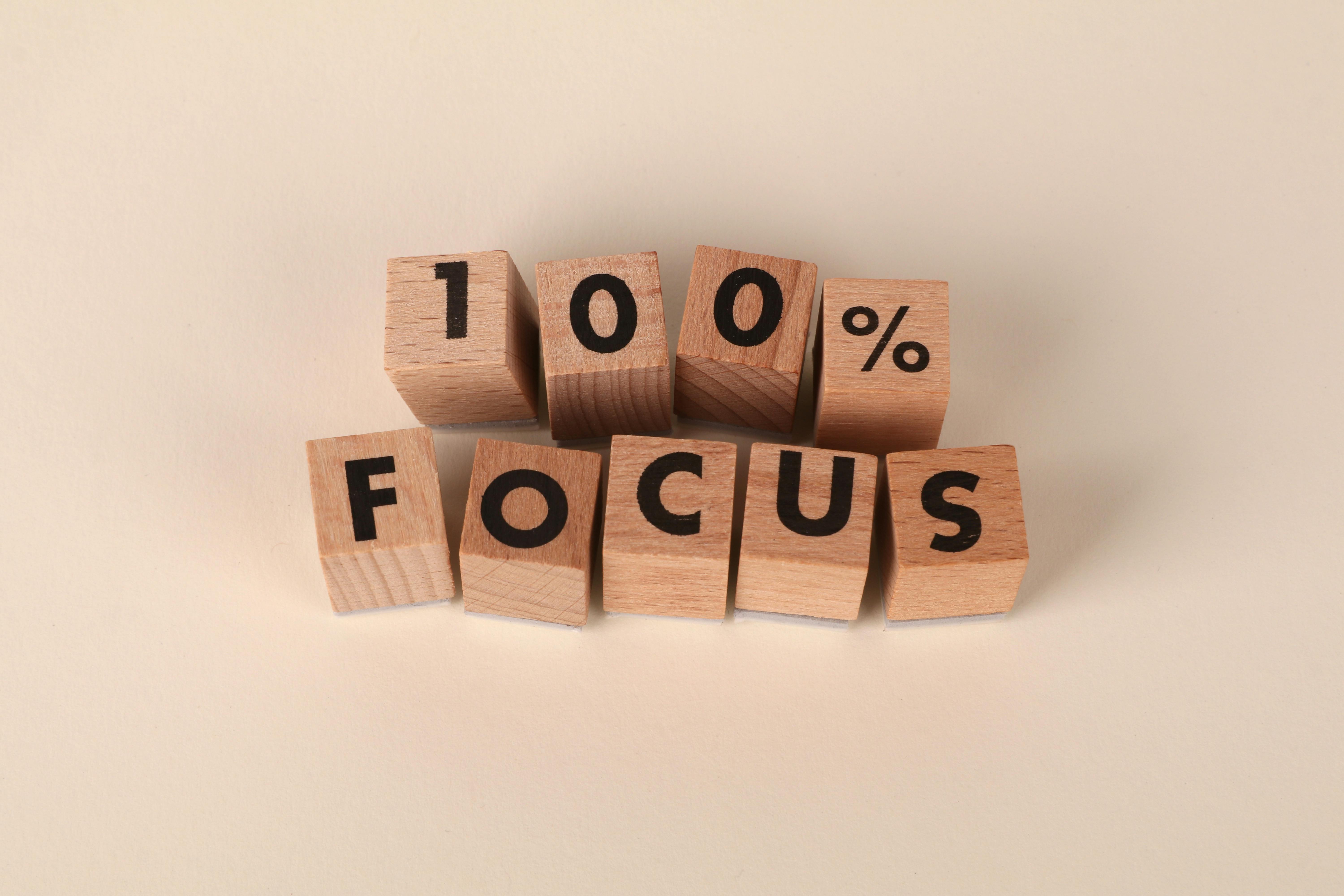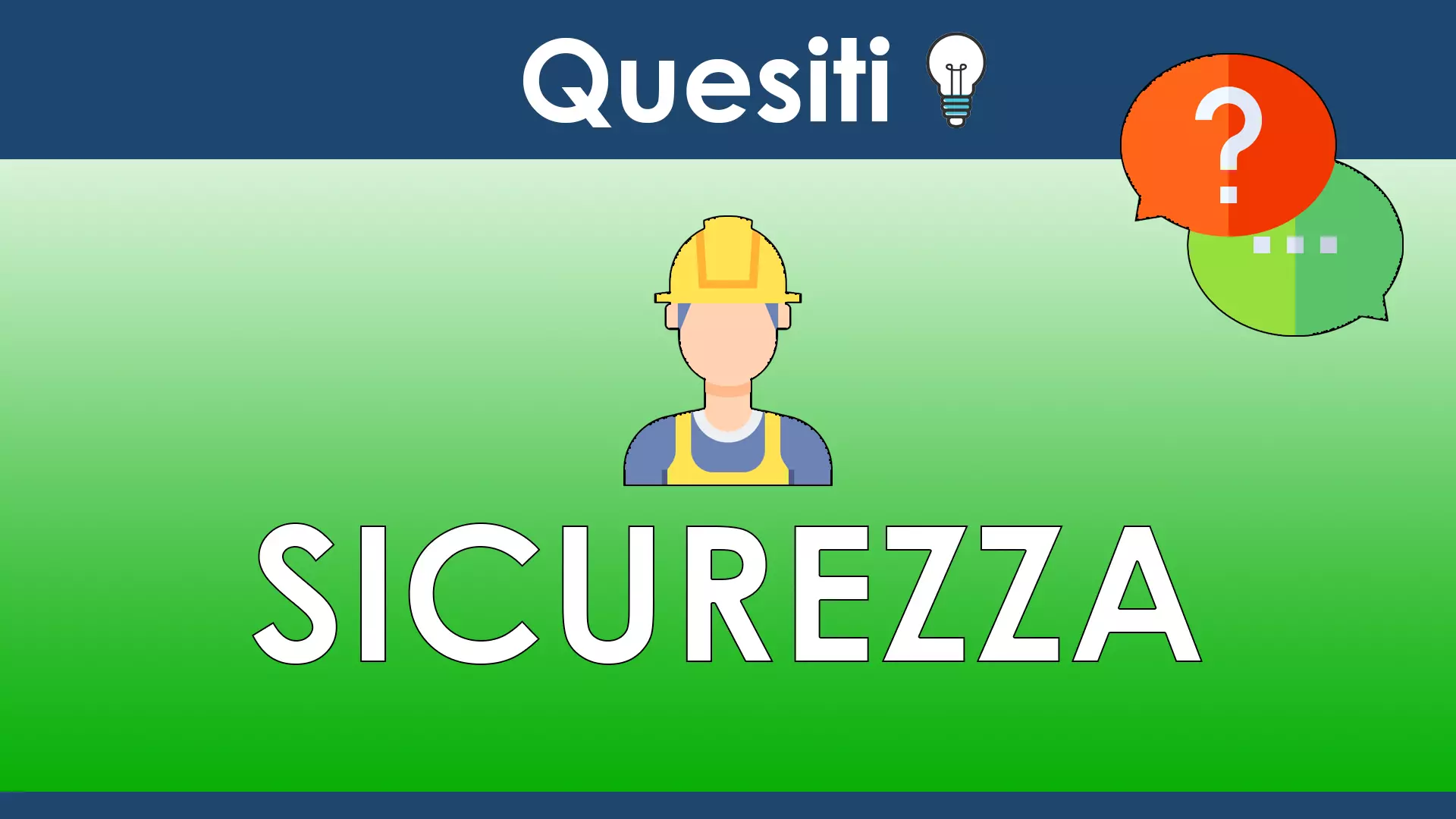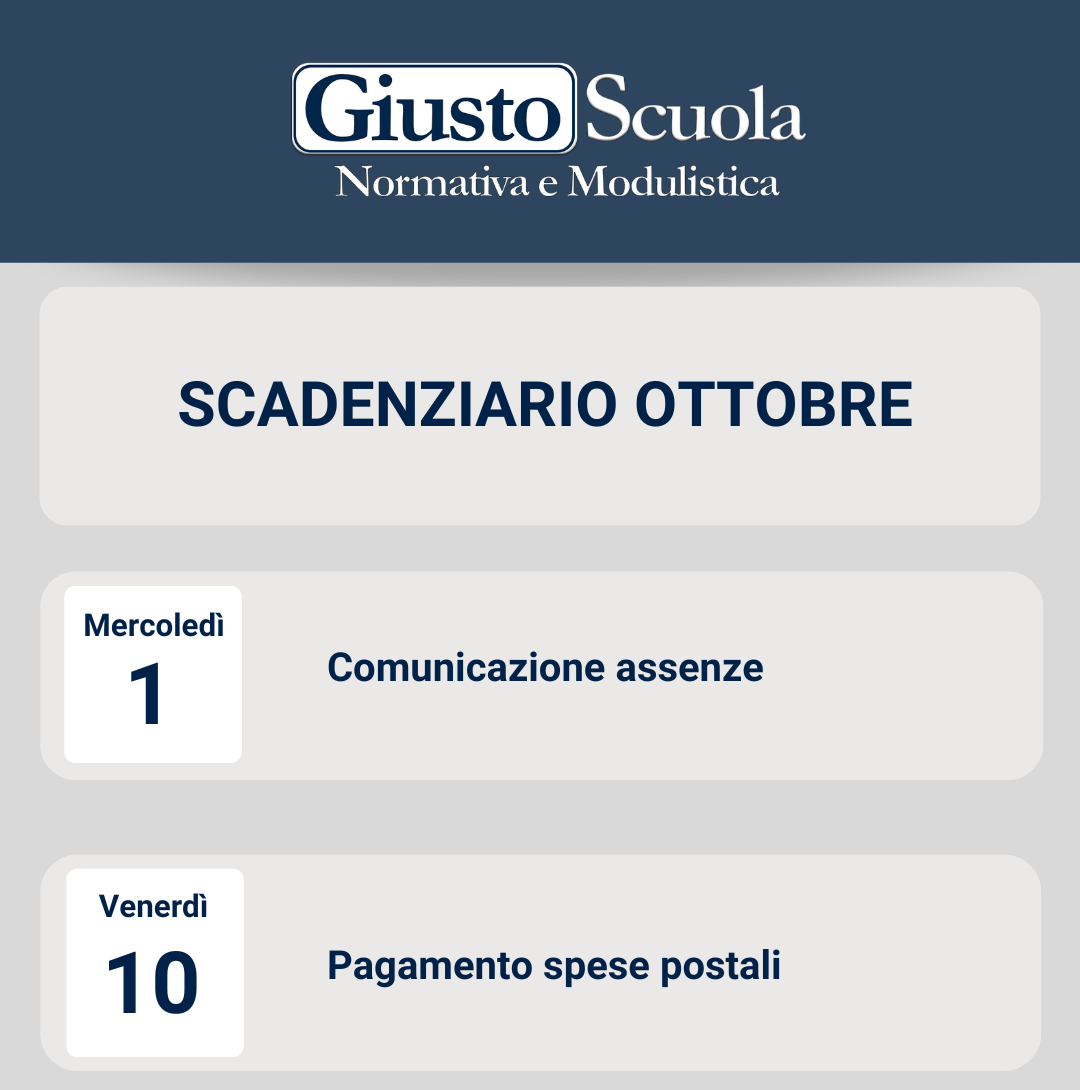Il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale dell’essere umana, che viene riconosciuto come tale non solo dall'articolo 34 della nostra Carta Costituzionale, il quale sancisce l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione per tutti, senza alcuna distinzione di sorta e, anzi, facendo espresso riferimento anche a chi in difetto di mezzi purché meritevoli[1], ma, anche, dall'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel quale si legge che: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita (...) Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:
(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria;
(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria;
(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.”
In tale cornice si sviluppa il dibattito giuridico e pedagogico sull'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), questione regolata principalmente dalla Legge 8 ottobre 2010, numero 170, rubricata "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", la quale riconosce la dislessia[2], la disortografia, la disgrafia[3] e la discalculia[4] come Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e tutela il diritto allo studio degli alunni con DSA garantendo loro percorsi individualizzati e l'uso di didattica personalizzata. A tal proposito, infatti, le successive linee guida ministeriali del 12 luglio 20211[5], emanate in attuazione della stessa legge, chiariscono che le istituzioni scolastiche devono garantire l’adozione di misure dispensative e l’uso di strumenti compensativi idonei a supportare il percorso scolastico. Tali linee guida si sono ritenute necessarie in quanto, per via della peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la summenzionata Legge 8 ottobre 2010, numero 17 apre in via generale un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104 del 1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. A tal proposito, ulteriori riferimenti normativi sono contenuti nel Decreto Legislativo numero 62 del 13 aprile 2017, che disciplina la valutazione degli alunni, sancendo all’articolo 1 che la valutazione: “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze”, precisando poi, all’articolo 11 commi 9 e 10, che essa deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato, pur riservando ai Consigli di classe la responsabilità della valutazione finale. Nello specifico si legge che “Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170[6], la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170[7], indicati nel piano didattico personalizzato”
Nello specifico il Piano Didattico Personalizzato ha natura di atto amministrativo interno a rilevanza esterna, con funzione integrativa del procedimento di insegnamento/apprendimento. Non è modificabile unilateralmente dalla scuola ed è soggetto a verifica e aggiornamento periodico, e viene inteso proprio come uno strumento tecnico-documentale necessario per garantire il diritto allo studio agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con altri Bisogni Educativi Speciali (BES)[8]. Viene redatto dalla scuola, sottoscritto dal dirigente scolastico, dai docenti, dalla famiglia e, se possibile, anche dallo studente, e deve contenere una pianificazione dettagliata delle strategie didattiche e valutative personalizzate da adottare nei confronti di un alunno con DSA.
Va notato che, pur garantendo il diritto a modalità di apprendimento adeguate[9], il legislatore non ha mai previsto un automatismo tra l’adozione del PDP - Piano Didattico Personalizzato - e la promozione dell’alunno. Al contrario, è richiesto il raggiungimento degli obiettivi minimi di competenza previsti per ogni singola materia, seppure con modalità compatibili con le difficoltà documentate dello studente. Infatti Il PDP, si può dire abbia una funzione prevalentemente didattica e compensativa in quanto non modifica, di fatto, il curricolo, bensì adatta le modalità di insegnamento e valutazione per consentire allo studente con DSA o BES di raggiungere gli obiettivi curricolari standard[10].
*-*-*-*-*
Alla luce dell’analisi normativa svolta finora, questo contributo si propone di esaminare criticamente la pronuncia del TAR Toscana del 4 febbraio 2025, numero 221, che ha confermato la legittimità della non ammissione alla classe successiva di uno studente affetto da dislessia, malgrado la predisposizione e attuazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). La decisione consente una riflessione sulla portata del diritto allo studio personalizzato e sui confini della valutazione scolastica nei confronti di soggetti tutelati.
Il caso di interesse nella disamina odierna trae origine dalla decisione, presa da un Consiglio di Classe di Firenze in fase di scrutinio, di non ammettere alla classe successiva uno studente affetto da un «disturbo specifico dell’apprendimento consistente in dislessia di grado medio. Lentezza nell’ esecuzione dell’atto grafico. Fascia clinica per problemi internalizzati e di ansia»[11] così come adeguatamente supportato da certificazione medica. Inoltre, ritengono che «la scuola, anziché aiutare il ragazzo, ha operato per emarginarlo dal contesto scolastico, e ciò in quanto lo studente aveva fatto la scelta di non cambiare istituto, al contrario di quanto consigliato dal corpo docente»[12]. Per tali ragioni, quindi, i genitori, ritenendo violati gli obblighi scolastici e le previsioni del PDP, proponevano ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale - competente per territorio, denunciando presunti comportamenti discriminatori, una valutazione scolastica viziata, un utilizzo scorretto di elementi valutativi e l’assenza di un adeguato piano di recupero. Sempre secondo i due genitori, infatti, lo studente avrebbe «subito, per tutto il corso dell’ anno scolastico,(...), un trattamento denigrante e discriminatorio e vi è stata la ripetuta errata valutazione del suo andamento, l’ emissione a suo carico di note del tutto ingiustificate, la valutazione di elementi che non rientrano nell’ ambito della esatta determinazione del voto in una materia, come gli appunti, ed infine, la deficitaria possibilità di recuperare attraverso interrogazioni suppletive»[13]. A ciò si aggiungevano doglianze circa la mancata attivazione di un dialogo efficace tra scuola e famiglia e la conseguente lesione del benessere psicologico dello studente, tutti elementi a dimostrazione della «indisponibilità del corpo docente a considerare in maniera adeguata le esigenze del ragazzo e a venire incontro ai suoi sforzi e al suo impegno» e ciò «è la causa dell’insufficiente rendimento dello studente, della sua non ammissione alla classe successiva e dei conseguenti disturbi psicosomatici sofferti»[14]. Per tali ragioni nel ricorso, i genitori dello studente chiedevano l’annullamento del provvedimento di bocciatura e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per un importo pari a 29.988 euro.
Il competente TAR adito dalla famiglia dello studente sulla base delle doglianze espresse, però, decideva per il rigetto del ricorso proposto ritenendolo inammissibile e comunque infondato. Già in fase cautelare, infatti, il Collegio osservava che«il giudizio di non ammissione alla classe successiva espresso dall’Istituto risulta sufficientemente articolato e motivato facendo leva sulle plurime gravi insufficienze riportate in materie fondamentali» continuando affermando che, in ogni caso, «i motivi di ricorso, per lo più generici, impingono nel merito della discrezionalità tecnico-valutativa degli insegnanti»[15].
Secondariamente il Collegio precisava che «il ricorso, (...) nella parte in diritto sia basato su di un’unica generica censura dalla quale non si evincono le disposizioni normative violate, né specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi. Tale unico motivo è invece basato su ipotesi o congetture che implicherebbero un’attività del giudice di ricerca dei vizi e delle prove non consona al giudizio impugnatorio di legittimità rimesso al giudice amministrativo. (...) Peraltro, nel caso in cui il provvedimento impugnato consista, come nella specie, nella valutazione del Consiglio di classe in ordine alla promozione o alla bocciatura degli alunni, esso, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, può essere annullato dal giudice amministrativo solo in presenza di gravi vizi procedimentali, ovvero di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, incompletezza, arbitrarietà, disparità di trattamento, tale da configurare un eccesso di potere. Tali vizi non sono stati in concreto rilevati dalla parte ricorrente, mentre l’unico macro-motivo dedotto entra nel merito delle valutazioni scolastiche e dei metodi educativi degli insegnanti e non fa emergere aspetti di manifesta illegittimità»[16]. Relativamente alle restanti condizioni ritenute negative per lo studente, il competente Tribunale Amministrativo evidenziava che il PDP, a differenza da quanto scritto nel ricorso proposto dalla famiglia, era stato correttamente attuato, proprio come risultava, invece in maniera inequivocabile, dalla documentazione prodotta, inclusa la relazione dettagliata della dirigente scolastica. Il piano prevedeva, ad esempio, la programmazione concordata delle verifiche orali e l’impiego di strategie metodologiche inclusive, tutte strategie e metodologie didattiche comprovatamente adoperate dal corpo docente di riferimento, ma, al contrario, non sempre ben tenute in considerazione dalla famiglia. Il Piano Didattico Personalizzato, come si è avuto modo di analizzare nella prima parte dell’attuale disamina, è firmato dagli insegnanti e dalla famiglia, nonché dallo studente stesso. Firmando tale documento tutte le parti si impegnano a rispettare quanto scritto e, infatti, in sentenza si legge «nel P.D.P. e in particolare nel “Patto con la famiglia e con lo studente” si prevedeva, fra i vari punti, e nell’ottica di una reciprocità degli impegni, “l’impegno della famiglia e dell’alunno nel rispettare le verifiche concordate, nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa»[17]. La decisione del Consiglio di classe, quindi, è stata considerata legittima in quanto basata su carenze gravi e diffuse in almeno sei materie, alcune delle quali fondamentali per il percorso di studi relativamente all’indirizzo frequentato dallo studente. La preparazione complessiva di questi, infatti, è risultata “gravemente lacunosa”, e ciò ha giustificato la deliberazione unanime del Consiglio. Quanto alle accuse di discriminazione e emarginazione, i giudici le hanno ritenute non provate e, anzi, ridimensionate dalla documentazione amministrativa. È stato sottolineato che l’atteggiamento dei docenti poteva essere interpretato, più che come rifiuto, come invito legittimo a riflettere sull’idoneità dell’indirizzo scolastico intrapreso. In sentenza si legge che «la tesi di fondo del ricorso, secondo cui gli insegnanti avrebbero modificato il loro atteggiamento ed operato una netta discriminazione verso l’alunno (...) appare poi del tutto sfornita di prova e palesemente infondata, apparendo più plausibile che i docenti - nei loro colloqui con la famiglia o attraverso la coordinatrice di classe - abbiano (del tutto legittimamente) invitato i genitori a considerare con rinnovata attenzione la scelta del tipo di indirizzo, verso il quale l’alunno non avrebbe mai evidenziato particolare interesse e motivazione (come osservato dalla dirigente scolastica nella propria relazione). D’altra parte, tale presunto atteggiamento ostile degli insegnanti potrebbe ricondursi ad una percezione soggettiva o ad una suggestione dell’alunno o dei suoi genitori (...)»[18]
Infine, la sentenza ha chiarito che la bocciatura non costituisce uno strumento punitivo, ma rappresenta un’opportunità di consolidamento delle conoscenze di base. Tale principio è stato enunciato anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato[19], cui i giudici aditi nel caso di specie si sono espressamente richiamati. La decisione in commento si fonda sull’equilibrio tra il diritto all’inclusione scolastica e la discrezionalità tecnica degli insegnanti. Ricordiamo, infatti, che uno dei principi cardine espressi nella Costituzione Italiana, all’articolo 33, è proprio la libertà di insegnamento che è intesa anche come piena libertà nella promozione e formazione della personalità degli alunni[20] anche, se supportati da giuste e legittime motivazioni, se questo ne comporta la bocciatura. La giurisprudenza amministrativa, infatti, riconosce che il giudizio del Consiglio di classe è espressione di una valutazione tecnica che può essere sindacata dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità o errore evidente[21]. La promozione non può dunque essere automatica né subordinata unicamente all’esistenza di un disturbo dell’apprendimento. L’inclusione scolastica autentica si realizza attraverso un accompagnamento consapevole e bilanciato, non mediante un abbassamento sistematico degli standard valutativi. Nel caso specifico, la valutazione complessiva dell’andamento scolastico, supportata da dati oggettivi e dalla documentazione amministrativa, è apparsa coerente e ragionevole.
La sentenza valorizza la corresponsabilità tra scuola, famiglia e studente, sottolineando che l’efficacia del PDP dipende anche dalla partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte. In conclusione si può dire che il diritto allo studio si realizza pienamente solo quando l’azione educativa si sviluppa in un contesto collaborativo, fondato sulla responsabilità condivisa tra tutte le componenti del sistema scolastico. La pronuncia contribuisce a delineare una cultura dell’inclusione consapevole, nella quale il principio di uguaglianza non si traduce in uniformità, ma in equità.
Commento TAR Toscana, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 221 di Federica Marotta su Scienza dell'amministrazione scolastica n. 3