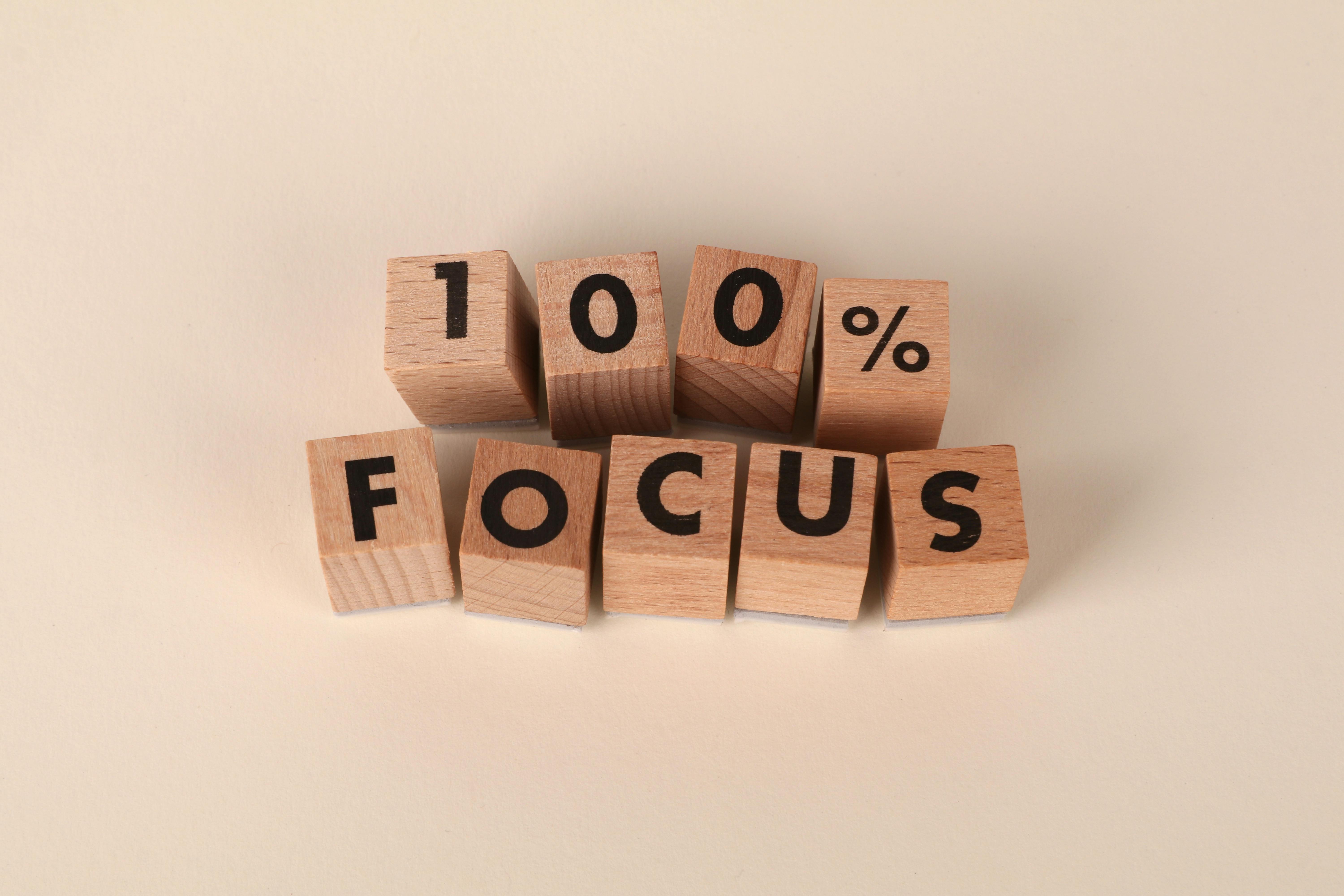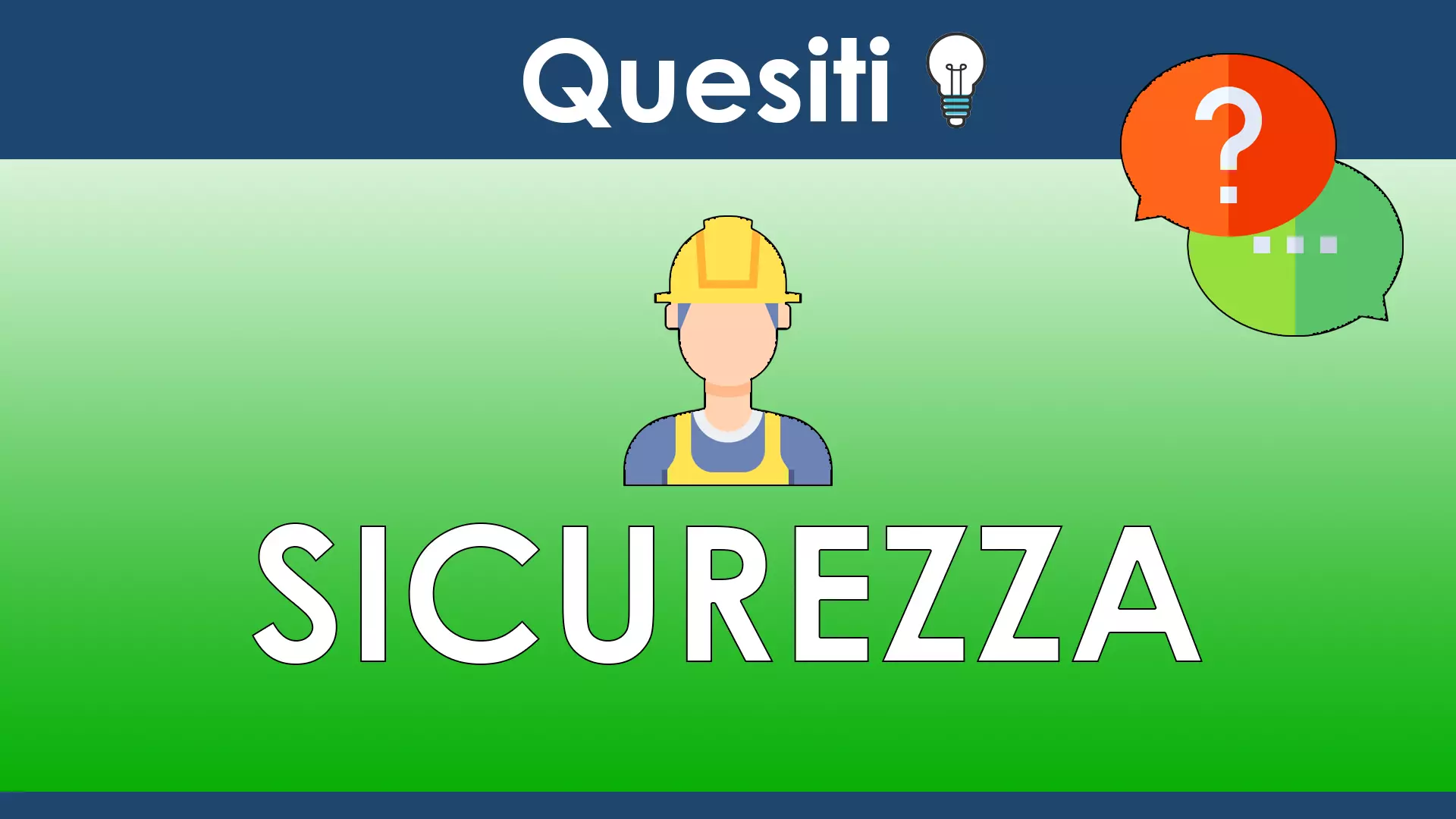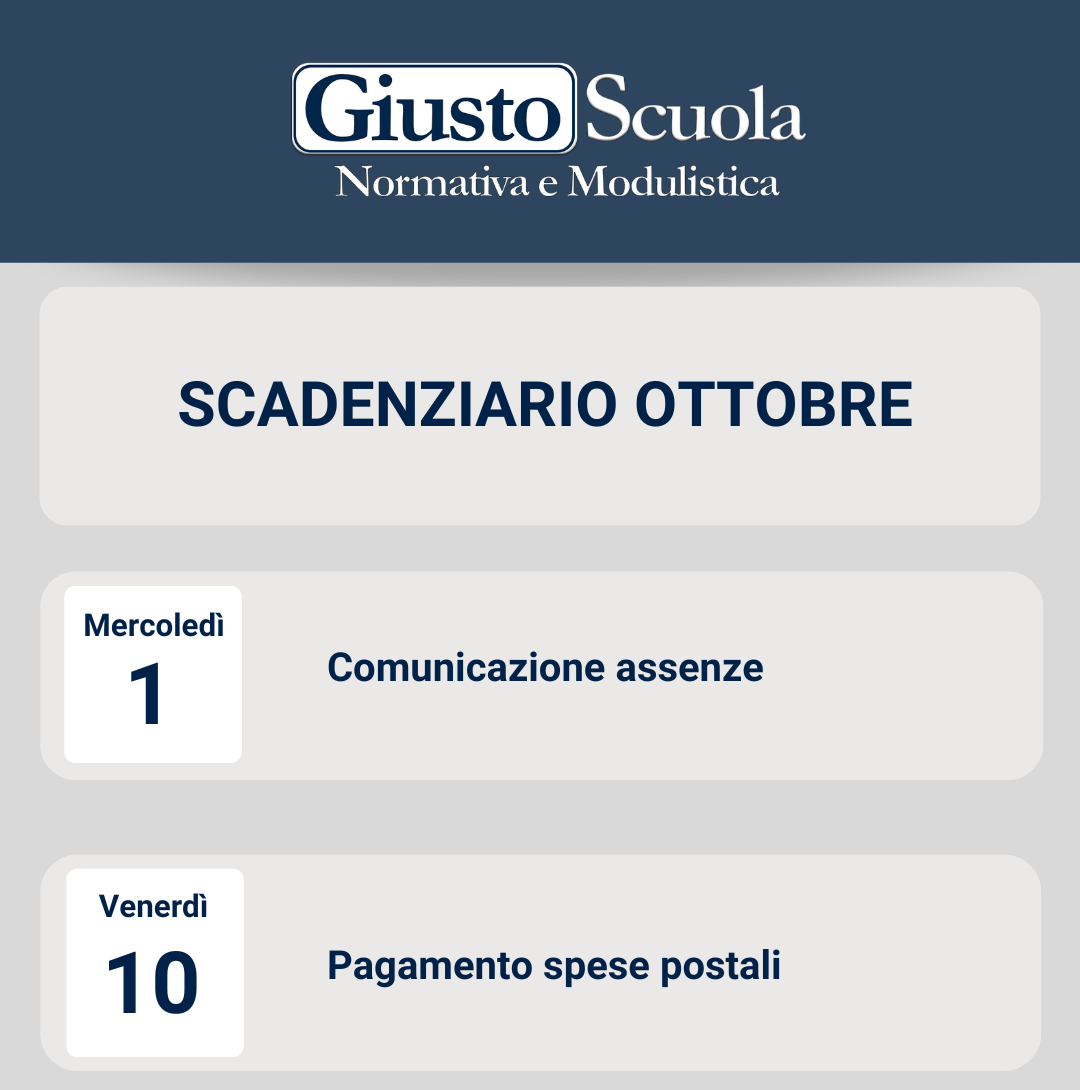La riforma della giustizia contabile e delle funzioni di controllo
“Una riforma libera tutti”. Considerazioni sul Disegno di legge “Foti”
Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile
La scuola italiana è inserita fra le amministrazioni pubbliche sottoposte al regime dei controlli, ma soprattutto tutti i dipendenti scolastici, dal dirigente al collaboratore scolastico sono passibili di giudizio davanti alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa. Ed è su questa parte della riforma della Corte dei conti(1) che mi soffermerò.
Nel corso del periodo pandemico la responsabilità erariale per colpa grave è stata “sospesa” per facilitare l’azione delle Amministrazione in un periodo di grave difficoltà operativa. Infatti, l’art. 21 del d.l. n. 76 del 2020 prevedeva per la prima volta il cosiddetto “scudo erariale”, escludendo la responsabilità per colpa grave dei funzionari pubblici e introducendo, invece, ipotesi di responsabilità omissiva. Tale previsione è stata più volte rinnovata, nel periodo 2021-2023, per la necessità di favorire la spesa delle risorse del PNRR e per accelerare l’azione amministrativa. Da ultimo in occasione del rinnovo il legislatore ha fatto espresso riferimento alla necessità di “riformare la responsabilità erariale” con uno complessivo intervento di sistema.(2)
È corretto ricordare come la necessità di un intervento legislativo è anche espressa dalla sentenza 132/2024 della Corte costituzionale. Secondo la Corte “il consolidamento dell’amministrazione di risultato e i mutamenti strutturali del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera, come si è già messo in evidenza, giustificano la ricerca, a regime, di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico, con l’obiettivo di rendere la responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo all’azione. In assenza di simili interventi, il fenomeno della “burocrazia difensiva”, dopo la scadenza del regime provvisorio oggetto della disposizione censurata, sarebbe destinato a rispandersi e la percezione da parte dell’agente pubblico di un eccesso di deterrenza tornerebbe a rallentare l’azione amministrativa. Ne sarebbero pregiudicati, oltre al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, anche altri rilevanti interessi costituzionali. Pertanto, una complessiva riforma della responsabilità amministrativa è richiesta per ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le più volte richiamate trasformazioni dell’amministrazione e del contesto in cui essa deve operare. Il legislatore non potrà limitare, come si è avuto cura di puntualizzare, l’elemento soggettivo al dolo - limitazione che ha trovato giustificazione esclusivamente in una disciplina provvisoria radicata nelle caratteristiche peculiari del contesto ricordato - ma potrà, nell’esercizio della discrezionalità che ad esso compete, attingere al complesso di proposte illustrate nelle numerose analisi scientifiche della materia, anche modulandole congiuntamente e considerando profili diversi da quello dell’elemento psicologico, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la fatica dell’amministrare senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa”.
Il DDL Foti si prefigge una riforma complessiva della giustizia contabile e delle funzioni di controllo con un intervento su diversi fronti, così sintetizzabili:
- definizione della colpa grave;
- la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
- il travisamento del fatto;
- l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Per quanto concerne la quantificazione del danno erariale, il risarcimento non potrà superare il 30% del danno accertato e non potrà eccedere il doppio della retribuzione annua del responsabile, fissando quindi un tetto massimo per le condanne. Si rammenta che nella disciplina attuale la responsabilità erariale richiede già particolari condizioni rispetto al sistema di risarcimento civilistico, non solo per il livello della colpa, (colpa grave), ma anche rispetto all’entità del danno da risarcire, visto che il giudice ha la possibilità di applicare il potere riduttivo sull’entità del danno accertato.
Inoltre, l’avvenuto spontaneo adempimento del pagamento di ogni importo indicato nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima. Quindi, ai sensi di questa norma, qualora l’agente provveda spontaneamente al pagamento degli importi indicati nella sentenza definitiva non si avranno ulteriori conseguenze in termini disciplinari o con riguardo ad altre sanzioni accessorie.
Con riferimento al decorso del termine per la prescrizione, si prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso “indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne siano venuti a conoscenza”. In caso di occultamento doloso del danno, “realizzato con una condotta attiva”, “la prescrizione di cinque anni si considera dalla data della sua scoperta” e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione».
Nell’attuale disciplina la buona fede deve essere documentata; invece, con la recente normativa non dovrà più essere provata ma sarà presunta fino a prova contraria, invertendo, pertanto, l’onere della prova, che viene posto a carico del giudice contabile.
Come anticipato nell’incipit, il personale scolastico entra in toto nella nuova configurazione della responsabilità, sia nella forma diretta che indiretta.
Non è un buon segno la resa di uno Stato che non riesce a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa contando sulla responsabilità etica individuale dei propri funzionari e deve ricorrere ad una sorta di impunità che alza il livello, al contrario, dell’irresponsabilità.
Ed ora veniamo al contenuto di questo numero.
Renato Loiero ricostruisce l’intero percorso del PNRR per il settore dell’istruzione, dal quadro dei finanziamenti ai risultati intermedi raggiunti nelle diverse linee di intervento. Nel complesso, l’autore rileva come la Missione 4 conferma una traiettoria strutturalmente positiva, con risultati consolidati sul fronte del capitale umano, dell’accesso all’istruzione e dell’innovazione nei modelli formativi. Restano tuttavia margini di miglioramento nel coordinamento tra i livelli istituzionali e nell’accelerazione delle fasi attuative ad alto contenuto tecnologico o infrastrutturale.
Licia Califano fa una ricognizione dei diritti “europei”, tra i quali la cittadinanza e la giustizia. In questo momento storico in cui questi diritti vengono messi in discussione in qualche Paese europeo, la riflessione ha un ruolo pedagogico molto rilevante.
Con Maurizia Maiano riapriamo lo sguardo sui sistemi scolastici europei, partendo dalla Germania. L’autrice inquadra la scuola tedesca nel sistema culturale e amministrativo, approfondendo, nel contempo, le tematiche che costituiscono il sistema linfatico della scuola: la relazione educativa, la competenza, l’apprendimento. L’analisi dedica un approfondimento anche alle fonti di finanziamento che evidenziano il forte divario con la spesa italiana per l’istruzione.
Lorenzo Pianfetti sviluppa la responsabilità penale del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Come afferma l’autore, egli, in particolare, quale intermediario tra il personale scolastico, dei cui interessi è portatore, e il comparto dirigenziale in materia di sicurezza, è chiamato a svolgere sostanzialmente una funzione consultiva, verificando che la valutazione dei rischi ad opera dei soggetti preposti sia svolta nel migliore dei modi. La prima parte dello scritto illustra l’impianto teorico del profilo penale generale della responsabilità e specifico del ruolo del RLS.
Vanna Monducci ricostruisce il panorama internazionale degli ITS attraverso l’illustrazione dei partenariati e accordi a livello europeo e non solo, fino ai paesi oltreoceano. Per definire la logica di tale sistema si riportano le conclusioni dell’autrice, secondo la quale nel quadro di una trasformazione economica e sociale sempre più interconnessa, l’internazionalizzazione del sistema ITS si configura non solo come un processo di apertura verso l’esterno, ma come una condizione strutturale per la sua maturazione e legittimazione. La capacità di dialogare con modelli formativi europei consolidati, di stringere partenariati strategici con attori globali e di sperimentare percorsi in contesti geopolitici diversi - come avviene oggi con la Francia, la Germania, gli Stati Uniti e i Paesi africani del Piano Mattei - rappresenta la vera misura dell’evoluzione del sistema ITS da rete nazionale a infrastruttura educativa di respiro transnazionale.
Francesco Nuzzaci, partendo dal nuovo recente modello valutativo dei dirigenti scolastici, prospetta, anzi auspica, l’inserimento della dirigenza scolastica nell’area della dirigenza pubblica di seconda fascia. Sostiene tale possibilità ripercorrendo l’esegesi normativa della funzione e trovando in tale funzione, non la specificità ma la complessità rispetto al modello standard. Conclude tale prospettiva con la possibilità futura anche della mobilità verso altre amministrazioni pubbliche.
Salvatore Milazzo fa un’esegesi del principio costituzionale della libertà d’insegnamento. Riproponiamo questo saggio alla luce del ddl. 1192 attualmente in corso di esame in commissione Senato che, fra le altre cose, prevede la rivisitazione degli organi collegiali “in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici”. È chiaro come una tale previsione non potrà che incidere sull’esercizio della libertà di insegnamento nella sua dimensione individuale e collegiale.
Federica Marotta, nell’osservatorio giurisprudenziale commenta la sentenza n. 221/2025 del TAR Toscana che affronta il delicato tema della valutazione scolastica di uno studente con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), rigettando il ricorso dei genitori che avevano impugnato la bocciatura del figlio. Il presente contributo analizza il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, il ruolo della discrezionalità tecnica degli organi scolastici e i limiti del sindacato giurisdizionale. La sentenza rappresenta un punto di equilibrio tra inclusione e garanzia degli standard formativi, ribadendo il principio secondo cui la personalizzazione dell’insegnamento non implica una promozione automatica.
Vincenzo Palermo, dedica il primo commento critico al film “La Gazza Ladra”, Regia: Robert Guéduiguian. Maria ama le ostriche, la musica classica e il suo nipotino, che dimostra un talento precoce per il pianoforte. Decisa a farne un pianista ad ogni costo, ha noleggiato un piano verticale e assoldato il maestro migliore di Marsiglia per dargli lezioni private. Ma Maria non ha i mezzi per sostenere queste spese e come la “gazza” di Rossini ruba la vita che luccica e fa la cresta sulla spesa dei suoi clienti, persone anziane di cui si occupa amorevolmente. La devozione la spinge però un po’ troppo lontana, firmando assegni che non potrà restituire. Un accidente scopre il suo gioco ma sotto il sole di L’Estaque qualcuno la ama e la solleva dai guai.
Come afferma l’autore, per mezzo di una commedia stralunata dagli accenti drammatici è possibile riflettere sulla precarietà economica, sulla solidarietà sociale e su nuove forme di socialismo. Il secondo film è “The Legend of Ochi”, Regia: Isaiah Saxon. La giovane Yuri, cresciuta in un remoto villaggio nel nord, è stata da sempre istruita a non uscire dopo il tramonto e a temere le misteriose creature della foresta note come Ochi. Ma quando trova un cucciolo di Ochi che si è perso, la ragazza cercherà in farlo tornare alla sua famiglia. L’opera recupera la dimensione nostalgica del cinema anni Ottanta, creando un rinnovato stupore attraverso un uso appassionato dell’analogico e di trucchi vintage. Il terzo film, anzi documentario, è “No Other Land”, Regia: Yuval Abraham,Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor che tratta dell’ amicizia tra l’attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval, amicizia nata nella quotidianetà della violenza brutale che il villaggio ha subito con le incursioni delle truppe israeliane.
Giuliana Costantini recensisce tre libri, molto diversi tra di loro, ma ognuno di essi manifesta un particolare interesse. Il primo libro è di Maurizio Trifone, Itanglese. Storie di parole da abstract a wine bar, Carocci editore, 2025. Attraverso una ricca serie di esempi, spesso divertenti, tratti dalla lingua quotidiana e dai giornali, il volume racconta la storia di numerose parole inglesi o angloamericane penetrate nell’italiano in diverse epoche e per vie talvolta imprevedibili. La finalità non è quella di deplorare l’ingresso di parole straniere nella nostra lingua o di imporre sostituti italiani, ma solo di fare luce su un fenomeno linguistico inarrestabile e aiutare il lettore a riflettere sulle risorse lessicali a sua disposizione.
Il secondo libro è di Fernando Virone Una vita in debug. Autobiografia di un paleoinformatico. Editoria digitale Bartolina, 2025. È un’autobiografia che attraversa una vita professionale di successo, ma l’aspetto più rilevante è la semplicità della narrazione e la modestia nel racconto dei successi stessi. Il mondo dell’informatica, solo apparentemente arido, si anima della vita dell’autore.
Il terzo libro è di Andrea Angeli, Fede, ultima speranza. Storie di religiosi in aree di conflitto. Edizioni Rubbettino. Mi piace chiudere con le parole di Tiziana Ferrario citate da Costantini: “Quando l’odio dilaga, la parola si spegne e parlano solo le armi, c’è chi resta al proprio posto, uomini e donne di fede come isole di accoglienza, coraggio e speranza”.
(1) “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale”. Aggiornamento Testo approvato alla Camera e trasmesso al Senato. Nuovo numero 1457 (non ancora calendarizzato).
(2) Art. 8, comma 5-bis, del d.l. n. 215 del 2023 che in sede di conversione ha prorogato lo scudo fino al 31 dicembre 2024.